Direzione della corrente elettrica
Colleghiamo il LED alla batteria del dito e, se la polarità viene osservata correttamente, si accenderà. In quale direzione si stabilizzerà la corrente? Al giorno d'oggi, tutti lo sanno dentro e fuori. E quindi all'interno della batteria da meno a più - dopotutto, la corrente in questo circuito elettrico chiuso è costante.
La direzione del movimento delle particelle caricate positivamente è considerata la direzione della corrente nel circuito, ma dopotutto, gli elettroni si muovono nei metalli e, lo sappiamo, sono caricati negativamente. Ciò significa che in realtà il concetto di "direzione corrente" è una convenzione. Scopriamo perché, mentre gli elettroni passano attraverso il circuito da meno a più, tutti intorno a loro dicono che la corrente va da più a meno... Perché è assurdo?

La risposta sta nella storia della formazione dell'ingegneria elettrica. Quando Franklin sviluppò la sua teoria dell'elettricità, considerò il suo moto come quello di un fluido, che sembrava fluire da un corpo all'altro. Dove c'è più fluido elettrico, scorre nella direzione dove ce n'è meno.
Per questo motivo Franklin chiamò corpi con un eccesso di fluido elettrico (condizionatamente!) Positivamente elettrizzati e corpi con una mancanza di fluido elettrico, negativamente elettrizzati. Ecco da dove nasce l'idea di movimento. cariche elettriche… La carica positiva fluisce, come attraverso un sistema di vasi comunicanti, da un corpo carico all'altro.
Successivamente, il ricercatore francese Charles Dufay nei suoi esperimenti con attrito elettrizzante scoprì che non solo i corpi strofinati, ma anche i corpi strofinati vengono caricati, e al contatto le cariche di entrambi i corpi vengono neutralizzate. Si scopre che in realtà esistono due tipi distinti di carica elettrica che, quando interagiscono, si annullano a vicenda. Questa teoria della doppia elettricità è stata sviluppata dal contemporaneo di Franklin, Robert Simmer, che si era convinto che qualcosa nella teoria di Franklin non fosse del tutto corretto.
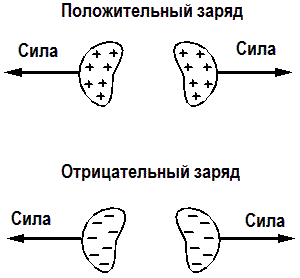
Il fisico scozzese Robert Simmer indossava due paia di calzini: caldi calzini di lana e un secondo di seta sopra. Quando si tolse contemporaneamente entrambi i calzini dal piede e poi tolse un calzino dall'altro, notò la seguente immagine: i calzini di lana e di seta si gonfiarono, come se prendessero la forma dei suoi piedi e si attaccassero nettamente l'uno all'altro. Allo stesso tempo, i calzini realizzati con lo stesso materiale, come lana e seta, si respingono a vicenda.
Se Simmer teneva due calze di seta in una mano e due calze di lana nell'altra, quando univa le mani, la repulsione per le calze dello stesso materiale e l'attrazione per le calze di materiali diversi portavano a un'interessante interazione tra di loro: diverse calzini come se si avventassero l'uno sull'altro e si attorcigliassero in una palla.
Le osservazioni sul comportamento delle proprie calze hanno portato Robert Simmer alla conclusione che in ogni corpo non ci sono uno, ma due fluidi elettrici, positivo e negativo, che sono contenuti nel corpo in quantità uguali.
Quando due corpi si sfregano, uno di loro può passare da un corpo all'altro, quindi ci sarà un eccesso di uno dei liquidi in un corpo e la sua carenza nell'altro. Entrambi i corpi diventeranno elettrizzati, opposti nel segno dell'elettricità.
Tuttavia, i fenomeni elettrostatici possono essere spiegati con successo utilizzando sia l'ipotesi di Franklin che l'ipotesi di Simmer di due forze elettriche. Queste teorie sono in competizione tra loro da tempo.
Quando nel 1779 Alessandro Volta creò la sua colonna voltaica, dopo di che fu studiata l'elettrolisi, gli scienziati giunsero alla conclusione inequivocabile che in effetti due flussi opposti di portatori di carica si muovono in soluzioni e liquidi: positivo e negativo. La teoria dualistica della corrente elettrica, sebbene non compresa da tutti, ha comunque trionfato.
Infine, nel 1820, parlando davanti all'Accademia delle scienze di Parigi, Ampere propose di scegliere una delle direzioni del movimento della carica come direzione principale della corrente. Era conveniente per lui farlo perché Ampere stava studiando l'interazione delle correnti tra loro e le correnti con i magneti. E così ogni volta durante un messaggio figuriamoci due flussi di carica opposta si muovono in due direzioni lungo un filo.
Ampere ha proposto semplicemente di prendere la direzione del movimento dell'elettricità positiva per la direzione della corrente e tutto il tempo per parlare della direzione della corrente, il che significa il movimento di una carica positiva... Da allora la posizione della direzione di la corrente proposta da Ampere è stata accettata ovunque ed è utilizzata e fino ad oggi.
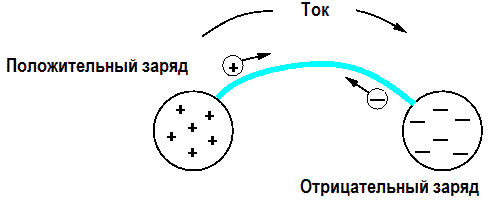
Quando Maxwell sviluppò la sua teoria dell'elettromagnetismo e decise di applicare la regola della vite della mano destra per comodità nel determinare la direzione del vettore di induzione magnetica, aderì anche a questa posizione: la direzione della corrente è la direzione del movimento di una carica positiva.
Faraday, da parte sua, osserva che la direzione della corrente è condizionata, è solo uno strumento conveniente per gli scienziati per determinare in modo inequivocabile la direzione della corrente. Lenz introducendo la sua regola di Lenz (vedi — Leggi fondamentali dell'ingegneria elettrica), utilizza anche il termine «direzione della corrente» per indicare il movimento di elettricità positiva. È solo conveniente.
E anche dopo che Thomson scoprì l'elettrone nel 1897, la convenzione della direzione della corrente era ancora valida. Anche se solo gli elettroni si muovono effettivamente in un filo o nel vuoto, la direzione opposta è ancora presa come direzione della corrente, da più a meno.
 Più di un secolo dopo la scoperta dell'elettrone, nonostante le idee di Faraday sugli ioni, anche con la comparsa di tubi elettronici e transistor, sebbene ci fossero difficoltà nelle descrizioni, rimane ancora il solito stato di cose. Quindi è più conveniente lavorare con le correnti, navigare nei loro campi magnetici, e sembra che questo non causi reali difficoltà a nessuno.
Più di un secolo dopo la scoperta dell'elettrone, nonostante le idee di Faraday sugli ioni, anche con la comparsa di tubi elettronici e transistor, sebbene ci fossero difficoltà nelle descrizioni, rimane ancora il solito stato di cose. Quindi è più conveniente lavorare con le correnti, navigare nei loro campi magnetici, e sembra che questo non causi reali difficoltà a nessuno.
Guarda anche:Condizioni per l'esistenza della corrente elettrica
